
Dedicato a Giorgio Gizzarone il libro di Dante Gentile Lorusso e Giovanni Mascia
Data: Monday, 06 August 2012 @ 13:51:50
Argomento: Cultura
 Tra Oratino e Arcadia. Giorgio Gizzarone, poeta del Seicento, è il titolo del volume scritto a quattro mani da Dante Gentile Lorusso e Giovanni Mascia che sarà presentato a Oratino il 9 agosto 2012. Un lavoro "particolarmente interessante ed encomiabile" - scrive Sebastiano Martelli nella "Presentazione" che abbiamo l'onore di pubblicare qui in anteprima. Un lavoro volto alla riscoperta del profilo biografico e dell'opera poetica inedita, in un vernacolo napoletano assai gustoso e divertente, di un protagonista dimenticato della vita letteraria della Roma di fine Seicento, nel terzo centenario della morte avvenuta a Oratino il 15 agosto 1712. Tra Oratino e Arcadia. Giorgio Gizzarone, poeta del Seicento, è il titolo del volume scritto a quattro mani da Dante Gentile Lorusso e Giovanni Mascia che sarà presentato a Oratino il 9 agosto 2012. Un lavoro "particolarmente interessante ed encomiabile" - scrive Sebastiano Martelli nella "Presentazione" che abbiamo l'onore di pubblicare qui in anteprima. Un lavoro volto alla riscoperta del profilo biografico e dell'opera poetica inedita, in un vernacolo napoletano assai gustoso e divertente, di un protagonista dimenticato della vita letteraria della Roma di fine Seicento, nel terzo centenario della morte avvenuta a Oratino il 15 agosto 1712.
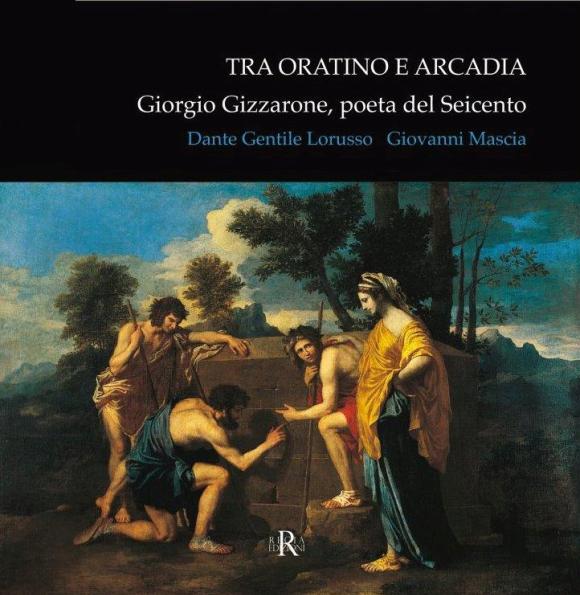
PRESENTAZIONE
del volume di Dante Gentile Lorusso e Giovanni Mascia
Tra Oratino e Arcadia. Giorgio Gizzarone, poeta del Seicento
Negli studi sulla cultura molisana risulta nettamente privilegiato il tempo storico che va dalla seconda metà del Settecento, ciò originato soprattutto dal livello alto di alcuni scrittori che tra Settecento ed Ottocento acquistano un ruolo di prestigio da Galanti a Longano, da De Attellis a Zurlo, da Cuoco a Pepe; ancora per tutto l’Ottocento non mancano esponenti di una intellettualità media di sicura dignità e in alcuni casi di rilievo nazionale, basti pensare agli agnonesi Marinelli, Amicarelli, Labanca, Gamberale, o ai campobassani Ziccardi e Albino. Molto scarsa è invece l’attenzione fino ad oggi rivolta alla cultura letteraria dal Rinascimento alla prima metà del Settecento, giustificata anche dalla scarsità e dal difficile reperimento di materiale documentario ma anche dall’assenza di protagonisti degni di rilievo.
Tutto ciò rende particolarmente interessante ed encomiabile il lavoro con il quale Dante Gentile Lorusso e Giovanni Mascia hanno recuperato un personaggio, Giorgio Gizzarone, di cui restava traccia solo in repertori sia pure importanti come quelli del Crescimbeni e del Gimma. Attraverso un puntuale scavo archivistico e bibliografico i due autori hanno fatto riemergere dal silenzio di tre secoli una figura che tra fine Seicento e primi anni del Settecento, aveva avuto una certa notorietà come letterato, soprattutto grazie alla sua affiliazione alla Accademia dell’Arcadia, che a partire dal 1690, anno della sua fondazione, elabora un nuovo gusto letterario destinato ad emarginare il barocco e ad aprire nuove strade alla pratica letteraria.
In assenza di fonti archivistiche più direttamente riferibili a Gizzarone, in gran parte andate perdute, sono ammirevoli la tenacia e la capacità dei due autori di questo libro di ricercare e utilizzare tutte le fonti archivistiche e bibliografiche possibili per recuperare anche le minime tracce della vita di Gizzarone, dalla sua nascita a Oratino, in un anno da collocare tra il 1660 ed il 1670, dove trascorre l’infanzia, prima degli studi in seminario, quindi la laurea a Napoli, l’acquisizione di buone competenze in utroque iure che gli saranno assai utili, quando si trasferirà a Roma, per assicurargli una buona qualità della vita grazie all’insegnamento privato, e anche per entrare negli ambienti curiali e nobiliari della capitale. Qui Gizzarone conquista posizioni rispettabili come letterato grazie anche alla protezione di un importante cardinale mecenate, Pietro Ottoboni: l’adesione all’Arcadia, col nome di Oratino Boreatico, e il ruolo avuto nella fondazione dell’Accademia dei Pellegrini – filiazione arcadica e repubblica platonica delle arti liberali, nonché consorzio di sodales pittori, scultori e architetti - e altre testimonianze raccolte da Gentile Lorusso e Mascia segnalano che il nome di Gizzarone aveva una circolazione rispettabile negli ambienti letterari che contavano, soprattutto nella capitale.

Attraverso un capillare lavoro di ricerca tra la documentazione edita e inedita relativa all’Arcadia, i due autori sono riusciti a raccogliere alcuni significativi tasselli biografici del nostro oratinese il quale, dopo i felici anni romani, rientra nella sua provincia di origine andando a svolgere la carica di arcidiacono della Cattedrale di Boiano. Roma con i suoi fasti barocchi è ormai lontana, Gizzarone tra ristrettezze economiche e malinconie esistenziali, vive un anticipato crepuscolo della sua vita, che si spegne nel 1712; sono anni segnati da difficoltà di ogni genere, da tristezza, rimpianti, nostalgia, cui solo la poesia riesce a dare qualche lenimento facendogli recuperare anche quella vena ironica, gioviale, teatrale propria della sua personalità.
E qui si inserisce la novità più importante di questo libro di Gentile Lorusso e Mascia: il ritrovamento, presso la Biblioteca Angelica di Roma, dove è depositato l’archivio dell’Accademia letteraria dell’Arcadia, di un mannello di composizioni poetiche inedite, alcune delle quali sicuramente appartenenti all’ultimo tempo della sua vita trascorso tra Oratino e Boiano: si tratta di cinque testi di cui quattro in dialetto napoletano, il quinto, un’anacreontica, in lingua italiana.
Dai testi in lingua superstiti e dalla testimonianza di Crescimbeni emerge il profilo di un letterato particolarmente abile nella caleidoscopica commistione di variazioni contenutistiche e formali di una materia illustre e abusata – quella umanistico-rinascimentale – e nella rifunzionalizazione della propria pratica poetica a scopi encomiastici. Classicheggiante e petrarchesca è la cifra sintattico-stilistica del Gizzarone, dalla consapevole imitatio del contesto teocriteo e virgiliano alla valenza metaletteraria e allocutiva di cui si carica la poesia stessa, al sonetto è affidato il compito di echeggiare la grandezza di un Arcade e di involare il vanto poetico al Cicerone o al Virgilio di turno. Fin qui nulla di nuovo, se non la perizia di un abile sonettista di maniera, che fa sì il verso a Petrarca, ma non esita a usare gonfie perifrasi, più vicine alle stravaganze barocche che al petrarchismo arcadico del vero e dell’utile.

Gizzarone non è un Arcade stricto sensu, giacché l’Arcadia praticò la lirica pindarica, anacreontica e petrarchesca per attingere a modelli formali e civili di limpidezza formale, contro la torbida sensualità della metafora e della perifrasi barocca In questo cantore borderline, si affaccia l’assimilazione di un precetto ideologico fondamentale per gli Arcadi: la funzione civilizzatrice della poesia italiana, organicamente inserita in un processo dialettico nazionale e unitario, ancora però non radicato nell’estetica del Vico e del Muratori, e ben lontano dai corposi contenuti civili del Parini, ma che comunque riecheggia, sia pure nel dettato barocco, il proposito di fondare glorie nazionali e di scalzare i modelli sublimi della prosa ciceroniana e della poesia virgiliana.
È certo che il capitolo più gustoso del lavoro di Gentile Lorusso e Mascia è quello in cui vengono proposti i testi inediti in dialetto. La permanenza a Napoli fu l’occasione per lo studente molisano di entrare in contatto con la società letteraria accademica, che lo porta ad acquisire quella pratica della poesia - in lingua, in dialetto e in latino - da esercitare come funzione socio-mondana durante le adunanze accademiche. Fu dunque quasi certamente il contesto accademico napoletano a favorire l’assimilazione di un modello linguistico di prestigio, il napoletano letterario, insieme a generi e forme di una tradizione che aveva trovato nella parodia del modello lirico petrarchesco e petrarchista (Felippo Sgruttendio, La tiorba a taccone) e di quello arcadico del Sannazaro (Vincenzo Braca, Arcadia cavota) la sua originale cifra stilistica.
La scelta del dialetto quale veicolo di poesia trova riscontro nelle posizioni di numerosi letterati meridionali del tempo che si riconobbero nelle Alluccate del napoletano antipetrarchista Niccolò Capasso inserito perfettamente nel programma culturale e letterario dell’Arcadia napoletana vivificata da Gregorio Messere, Giuseppe Porcella, Giovan Battista Palma, Gaetano Argento, Saverio Pansuti, Gregorio Caloprese, tutti partecipanti al sodalizio fin dal 1691 e da Lionardo di Capua dal 1692; Maioli D’Avitabile svolgeva il ruolo di collegamento con Roma. Capasso polemizzò con Gravina, Amenta, Grimaldi, Messere ed altri, difendendo il ricorso al dialetto quale espressione di una sensibilità critica rispetto all’esperienza linguistica toscaneggiante e al marinismo diffusamente imperante nell’Italia meridionale. Quando Giacomo Castelli nel 1754 nei Ragionamenti delle origini della lingua napoletana confutava la dipendenza dal greco del dialetto napoletano nel tentativo di affrancarlo da ogni soggezione classicista e Francesco Oliva nella Grammatica della lingua napoletana dava man forte a questa tesi, il dialetto aveva assunto consolidata dignità di lingua.
Ma la questione non si esauriva nell’affermare in loco tesi pro e contro il dialetto; ha osservato giustamente Vallone che la polemica era rivolta contro l’ufficialità della letteratura aulica e toscana a vantaggio di un filone che vedeva il canto popolare e plebeo prevalere in un contesto di ricerca globale di forme e contenuti nuovi dopo l’esperienza barocca.
Di qui si spiega come i temi erotici di un’Arcadia sentimentale, sostenuti dalla poetica crescimbeniana, possono essere declinati dal pastore arcade Oratino Boreatico nei suoi cimenti poetici secondo i modi “bassi”, alternativi della tradizione dialettale napoletana, specializzatasi nel contrapporre alle raffinate e letterarie stilizzazioni petrarcheggianti, nonché della poesia bucolica colta, un linguaggio dai referenti realistici e dalle metafore deformanti : «Mo che Zezolla mia tutta sfarzosa / esce da la capanna accossì bella / come da lo mazzuoccolo la rosa , / oh bene mio, e quanta è ghianca, tonna e squasosella [vezzosella], / che pare na recotta tennerella». La ninfa amata dal pastore è evocata con un nome ridicolo, Zezolla, ipocoristico dissacrante e allusivo, comune dei canzonieri parodici (da una parte esso richiama, come ricordano bene gli autori, al nome di Zeza, moglie di Pulcinella nelle farse carnevalesche; dall’altra parte c’è da aggiungere che in alcuni dialetti campani, zezolla, è anche nome comune di origine onomatopeica, dal significato di ‘piccola cagna’, ‘cagnolina’, da cui il nome proprio riceve particolari suggestioni caricaturali). Si veda ancora come lessico, forme e luoghi comuni della lirica amorosa siano comicamente contraffatti nelle raffigurazioni parodiche e giocose dell’abate poeta molisano: «Mo che Zeza va a cogliere viole / coll’uuocchie fa sguiglià li gelsomini: / venga ccà, venga ccà chi vedé vole / mascarato da femmene lo sole, / che co li raggie suoie belli e devine / m’ha abbrusciato lo core , e lo stentine; Se lo pietto de Zeza / pe bolontà d’ammore / è sebortura de st’affritto core, / la voglio ncoronà se m’è conciesso / de fronde de Cipriesso, / ma è meglio de cepolla, e non me sbaglio / pocca essa sempre a me fa magnà l’aglio».
Parodia e perizia tecnica si coniugano in questi versi con una qualità particolarmente apprezzata nell’uomo di lettere del Settecento: la “lepidezza”, ovvero la piacevolezza e l’arguzia di spirito, che erano, peraltro, le doti particolarmente richieste nei dotti trattenimenti letterari delle adunanze accademiche, così come ci testimonia lo storico dell’Arcadia e suo custode generale, Giovan Mario Crescimbeni.

In tale clima, si giustificano ampiamente le scelte poetiche di Giorgio Gizzarone. Da qui l’interesse per una popolana «ghianca tonna e squasosella» (diminutivo di vezzosa, con evidente intenzione di resa più intricante dell’immagine della donna-fanciulla) ma che non condivide nulla con le Filli o Clori, e le caratteristiche di un cuore distante da quello dei Coridone e dei Tirsi dei canzonieri arcadici. Sembra quasi che abbia ragione Francesco De Sanctis da Ferrazzano quando definiva nel 1741 il poeta di Oratino «troppo amico di conversazioni allegre» ed autore di «facezie» che gli giovarono l’arcidiaconato di Boiano. Ma l’allegria o l’ironica parodia della realtà non è certo un peccato; ché anzi fanno ascrivere questo amabile verseggiatore di fine Seicento a quella schiera di poeti attratti dai sottili piaceri della vita ma pervasi, pure, da soffusa malinconia, oscillante, egli, tra il progetto e il rifiuto del sogno e della realtà.
In tre sestine di endecasillabi carichi di sensualità e di passione, Zeza, «Zezolla mia», con un’altalena d’immagini arcadiche e popolari, rese in una lingua dissacrante ed efficace, è presentata all’atto di uscire dalla sua capanna bella come un bocciolo di rosa e gustosa nelle forme al punto da sembrare «na recotta tennerella». Ella «tra l’autre belle, è la chiù bella et cetera» («et cetera» in clausula è un significativo invito al lettore a fantasticare sulle qualità non dette) ha rapito il cuore del poeta ed anche «lo stentine»; e quando l’amore rapisce cuore e intestino, è d’obbligo l’invito alle compagne della donna a mettere mano a «frauto, zampogne, colascione» (=calascione, sorta di liuto) per cantare assieme le bellezze di Zeza.
Secondo un copione nel quale ogni amante aspira a trasformarsi in qualcosa per restare più tempo con l’amata, Gizzarone si rivolge ad Amore in tono confidenziale, «Siénteme mò», chiedendo di poter essere trasformato in febbre malarica «acciò, che stanno po co’ Zeza bella / s’essa è fredda pe mme pozza abbrusciare; / se p’autro abbruscia haggia la tremmarella».
La «scerta» di cipolle, con la quale cingere il capo della donna invece che con un serto di foglie di cipresso, è motivata in un madrigale in cui ritorna il tema dell’amore non corrisposto. Che la «verginella è simile alla rosa» e che il fiore fosse «riso d’amor [...] | pregio del mondo e fregio di natura | [...] d’ogni ninfa e pastor delizia e cura», è un topos d’ogni tempo; che Zeza (talvolta Zezolla), Lucrezia per l’anagrafe italiana, sanguigna figura di popolana meridionale riottosa al punto da «far mangiar l’aglio» al suo spasimante, meritasse come riconoscimento della sua bellezza un serto di cipolle, è una novità che la dice lunga sulla cifra culturale della esigua, ma significativa produzione poetica di Giorgio Gizzarone.
Negli inediti in dialetto emerge dunque un rovesciamento dei topoi classici: : il cimento è una parodia delle ecloghe amebee sugli amori di ninfe e pastori: non più riecheggiano i nomi di Fillide e di Amarillide, di Tirsi e di Coridone, ma della sgraziata Zezolla, che si carica di tutte le valenze onomastiche etno-antropologiche del molisano; il sonetto sulla trasformazione dell’amante in febbre quartana è una parodistica rivisitazione delle metamorfosi classicheggianti; la ghirlanda è l’irrisione dei serti di alloro e di cipresso soppiantati da quelli di cipolla. Insomma, il sublime decanta vertiginosamente in corpose espressioni sintagmatiche folcloriche, di sapida pregnanza regionalistica: siamo di fronte al consolidato meccanismo del canone e della devianza, del centro e della periferia, del classicismo e dell’anticlassicismo, dell’ordine e dell’anarchia, della norma linguistica e dello scarto.

Nell’epistola indirizzata al padre, affettuosa nei sentimenti resi in una lingua altalenante tra vezzo e dissacrazione, si rivolge a lui chiamandolo «Tata ammorosiello», «Tatillo», «Tata tra l’auti tate grasse, e tunno», lo invita ad essere sereno e contento perché il figlio lo è nel luogo dove si trova. Manifesta, infatti, il piacere di ritrovarsi in Arcadia, dove regna equilibrio e pace tra gli abitanti «che face a la vertù le bone spese» al punto che la qualità della vita sembra allungare la vita stessa. In questo mondo tutto diviene con naturalezza e «se chiamma peccerillo ammore / pecché non cresce maie maleziuso / e se è cieco pe guida have l’onore». Inoltre sono bandite tribolazioni e tristezze. Il pensiero, in fine, ancora una volta corre a Zeza, «idolo ammato, / Zeza, che s’assomiglia a n’Armellino».
Chiude il breve canzoniere inedito una canzonetta in lingua rivolta al Rettore del Seminario di Boiano nella quale il poeta fa una sorta di bilancio della sua vita che ormai scorre lontano dai luoghi che ha frequentato in gioventù, amati per avervi speso gli entusiasmi migliori. Lo coglie l’uggia della periferia, la mancanza dei sodalizi che ha faticato a costituire, la carenza di stimoli culturali. Si sente «vilipeso e schernito / da più fidi aborrito», ma non per questo sconfitto; anzi si dichiara tanto forte da «dar morte alla Morte». La povertà nella quale è precipitato gli mozza il fiato, ma è fiero di resisterle con dignità. Prega la sua buona stella di riportarlo a Roma nell’orbita di papi e cardinali, per continuare a esprimere il suo talento, come quando, grazie al favore accordatogli da principi e letterati, ha avuto modo di farsi conoscere ed annoverare nella schiera degli eletti. Ma i sogni restano tali e quello che conta è la misera realtà nella quale è costretto a versare.
Per concludere: brioso spaccato di realtà popolare resa attraverso efficace e coerente strumento linguistico, questa parte vernacolare dell’inedito breve canzoniere di Giazzarone; vagheggiamento soffuso di malinconia per l’eden perduto nel componimento che chiude la raccolta: il tutto testimonianza di un microcosmo che dalla periferia andava verso il centro e da qui ritornava, a contatto con realtà sociali e culturali diverse, ma unite da filo rosso che coniugava tradizione ed innovazione all’egida di canone ed anticanone, in letteratura come nella vita romana o vissuta in un oscuro borgo di periferia, tra «scerte» di cipolle o aglio puzzolente. Sullo sfondo: Ninfe e pastori, caprette ed uccelli che parlavano in latino, mentre «Magra, negra, scontenta, e poverella / era arraddutta affè la poesia, / e non tenenno straccio de gonnella / s’assomigliava a la Felosofia»; il poeta la vede e le chiede ragione del suo stato. «Chella chiagnenno no potea parlare; / isso s’abbede ca steva allancata, / aprie la porta, e la facette entrare: / e de conciette havennola ngrassata / a sto Munno l’ha fatta arretornare / chiu ghianga, e allegra che non è na Fata».
A merito di questo libro di Gentile Lorusso e Mascia va sottolineato anche il ricco apparato iconografico, non casuale ma sicuramente funzionale alla ricostruzione storico-letteraria e biografica di Gizzarone, un’operazione possibile grazie alle competenze ed esperienze dei due autori, mi limito a ricordare: Uomini virtuosi. Il “caso” Oratino nella geografica culturale molisana (2002) di Gentile Lorusso e Affreschi per il papa. Arte, fede e storia nel chiostro e nel convento di Toro (2008), di Mascia.
Sebastiano Martelli


|
|